Un viaggio attraverso le Città invisibili e il loro legame con la realtà contemporanea
di Ginevra Luxardo
È il 1972 quando Italo Calvino, avvicinatosi già da qualche anno alla letteratura combinatoria, pubblica il romanzo Le città invisibili: un romanzo che vede intrecciarsi l’una con l’altra le descrizioni di cinquantacinque città inventate, ognuna con un nome di donna. Esse sono divise a seconda dei temi di cui trattano: la memoria, il desiderio, i segni. La cornice narrativa è data da alcuni dialoghi tra Marco Polo e l’imperatore Kublai Kan, il quale, impossibilitato a visitare i luoghi del suo impero, chiede al giovane di raccontargli ciò che ha potuto vedere durante i suoi viaggi. Talvolta l’imperatore teme di essere preso in giro da Marco Polo. Egli infatti racconta di aver visitato città fatte interamente di vetro, città solamente costituite da tubature d’acqua e città sostenute da ragnatele, sospese nel vuoto. Tuttavia, altre volte Kublai Kan si lascia affascinare dalle narrazioni del viaggiatore e quasi si convince del fatto che quei luoghi tanto irreali esistano davvero.
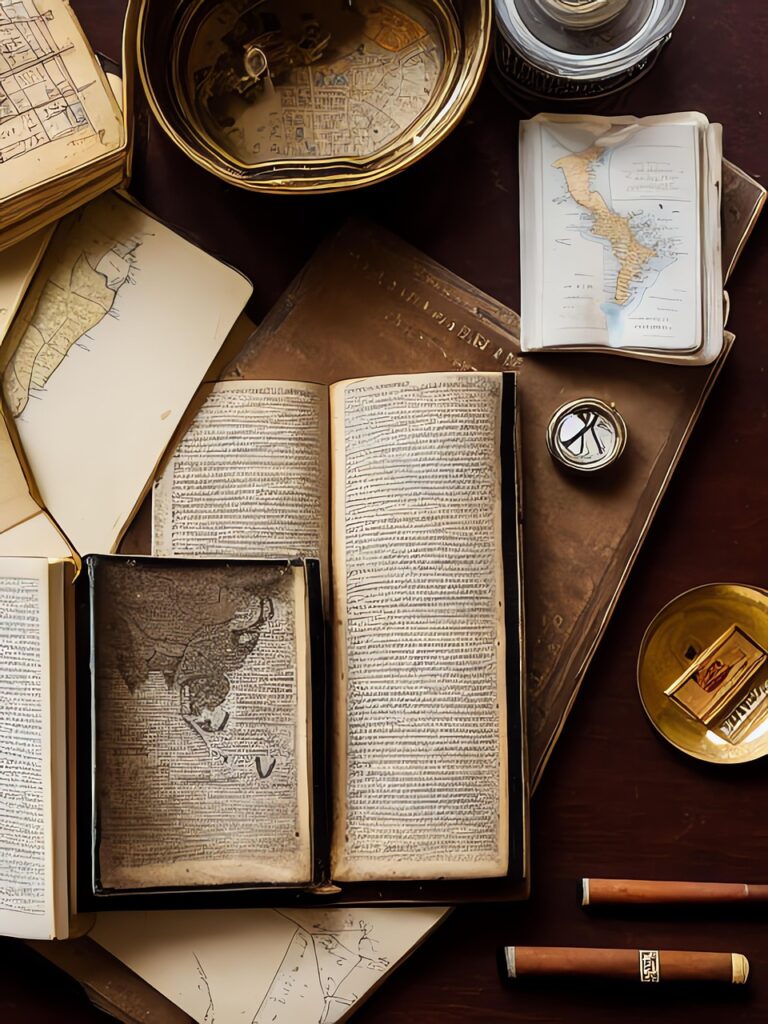
Così come l’imperatore, anche il lettore è portato a chiedersi se, da qualche parte nel mondo, ci siano città come quelle descritte da Calvino. Sebbene l’autore, nella presentazione del romanzo, affermi che «nelle Città invisibili non si trovano città riconoscibili. Sono tutte città inventate», esse, chiudendo gli occhi, appaiono estremamente reali e vicine al mondo che ci circonda. Alcune di loro, infatti, presentano elementi assai simili a quelli che caratterizzano la realtà contemporanea. Le città continue, le città e gli scambi, le città nascoste: ognuna di queste può apparire al lettore come un vero specchio delle città moderne. Andiamo adesso a scoprirne alcune.

Le città continue
L’ultima città continua, chiamata Pentesilea, è una città priva di mura e di porta d’ingresso. È una città che si estende in lungo e in largo, tanto che è difficile per i visitatori comprendere dove si trovi il suo centro e dove essa finisca. «Tu certo immagini di vedere levarsi dalla pianura polverosa una cinta di mura, d’avvicinarsi passo passo alla porta, sorvegliata dai gabellieri che già guatano storto ai tuoi fagotti. Fino a che non l’hai raggiunta ne sei fuori; passi sotto un archivolto e ti ritrovi dentro la città. […] Se credi questo, sbagli: a Pentesilea è diverso. Sono ore che avanzi e non ti è chiaro se sei già in mezzo alla città o ancora fuori. Come un lago dalle rive basse che si perde in acquitrini, così Pentesilea si spande per miglia intorno in una zuppa di città diluita nella pianura». Non è forse vero che questa città assomiglia alle metropoli odierne, che sembrano espandersi sempre di più per essere abitate da una popolazione in costante crescita?
Le città e gli scambi
A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri a seconda se segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili sono tanti che non si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via: le case vengono smontate; restano solo i fili e i sostegni dei fili. […] Così viaggiando nel territorio di Ersilia incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare: ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma».
Questa città viene descritta come un groviglio di fili intricati, fili che rappresentano i rapporti umani, fili che il tempo non è capace di corrompere. Proprio per questi fili incorruttibili Ersilia appare la perfetta rappresentazione della nostra realtà: una realtà fatta di rapporti imperituri tra le persone, capaci di resistere anche quando tutto il resto svanisce. Rapporti tra esseri umani che trovano la loro ragion d’essere l’uno nell’altro.
Le città nascoste
Berenice è una città dal duplice volto: in essa si alternano giusto e ingiusto, bene e male. «Nel seme della città dei giusti sta nascosta a sua volta una semenza maligna; la certezza e l’orgoglio d’essere nel giusto – e d’esserlo più di tanti altri che si dicono giusti più del giusto – fermentano in rancori rivalità ripicchi, e il naturale desiderio di rivalsa sugli ingiusti si tinge della smania d’essere al loro posto a far lo stesso di loro. Un’altra città ingiusta, pur sempre diversa dalla prima, sta dunque scavando il suo spazio dentro il doppio involucro delle Berenici ingiusta e giusta». Essa è dunque una città in cui il giusto non riuscirà mai a soppiantare l’ingiusto e, allo stesso modo, l’ingiusto non riuscirà mai a prendere in eterno il posto del giusto. Quest’ultima città è forse la più vicina al mondo reale: nei secoli passati pace e guerra, giustizia e ingiustizia si sono sempre alternate, non lasciandosi però mai sconfiggere l’una dall’altra. Berenice, dunque, non è forse la perfetta rappresentazione dei cambiamenti immobili che caratterizzano la nostra realtà?

Una nuova visuale del mondo contemporaneo
Leggendo Le città invisibili, il lettore si trova di fronte a un’irrealtà reale e, spesso, è portato a chiedersi se quelle descritte da Marco Polo siano davvero città inventate. Nonostante l’autore stesso affermi che nessuno dei luoghi visitati dal viaggiatore sia davvero esistente, si ha l’impressione che ognuno di essi abbia uno stretto legame con il mondo che ci circonda. Calvino è riuscito a rappresentare la nostra realtà attraverso una prospettiva differente, fantastica, quasi magica. Se molti romanzi permettono ai lettori di conoscere nuovi mondi, Calvino è riuscito a far conoscere il mondo contemporaneo attraverso un punto di vista diverso e nuovo.

