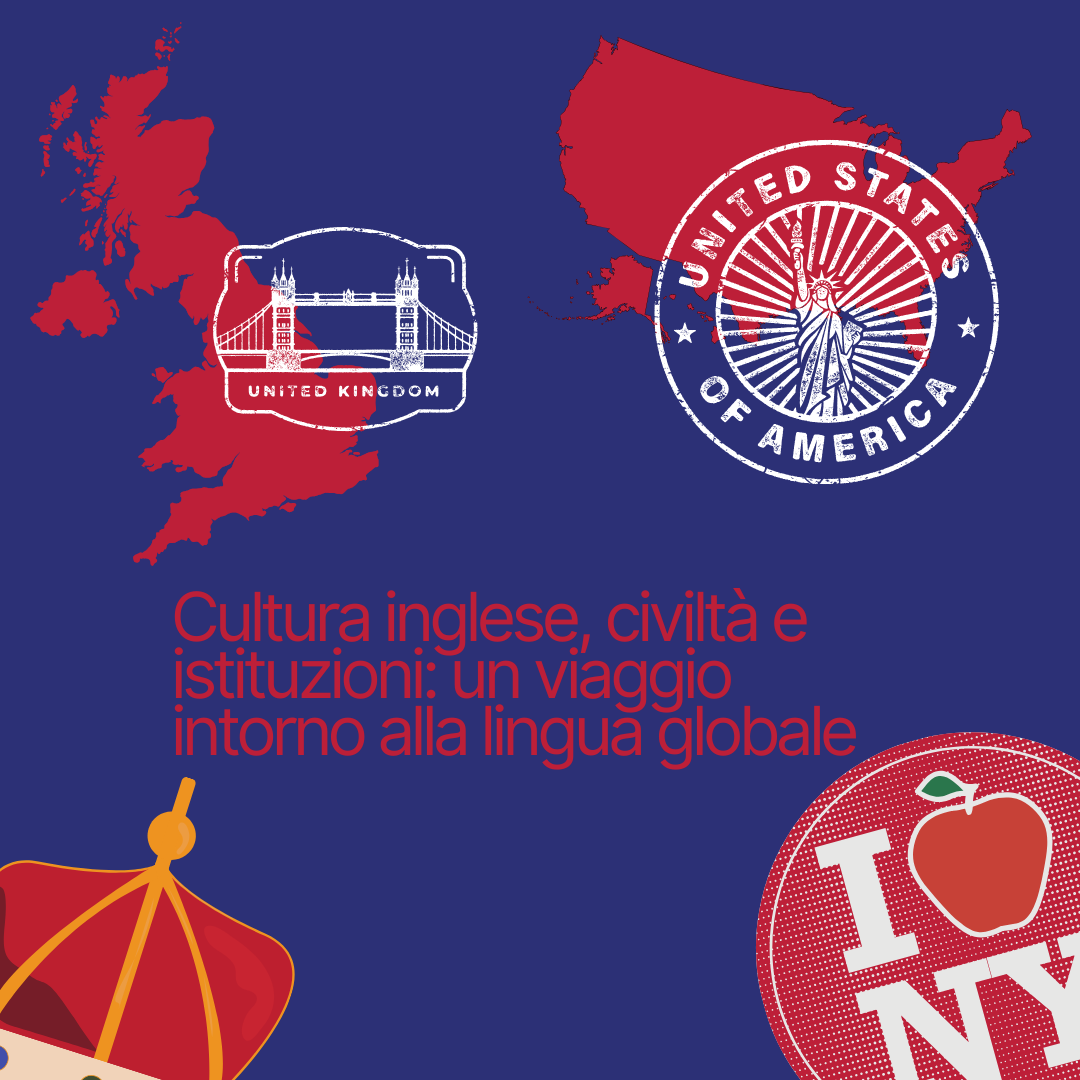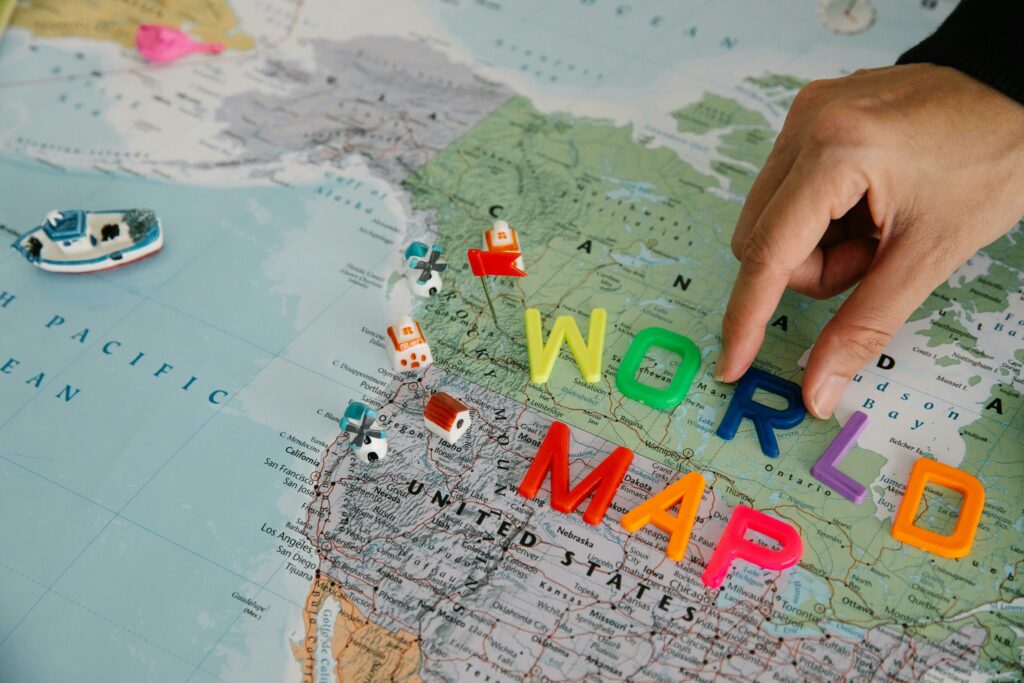di Iris Valerio
Introduzione
La democrazia è una forma di governo che trova i suoi natali nell’Atene del V secolo A.c. e che prevede il controllo del potere politico da parte del popolo per mezzo di libere elezioni.
La democrazia rappresenta, soprattutto in Occidente, una forma di governo perfetta al punto da poter generare la pace perpetua teorizzata da Kant. Secondo il filosofo di Königsberg le repubbliche risultavano più stabili rispetto ai regimi autoritari (Kant, 1795). La Teoria è stata rivisitata da Doyle nel 1983 che, adattandola al contesto storico, ha affermato che un mondo costituito da sole democrazie sarebbe un mondo idealmente stabile e pacifico.
Tuttavia, ad oggi, solo 64 Paesi su 193 sono democratici e solo l’8% della popolazione globale vive all’interno di una democrazia completa.
Dalla teoria della pace kantiana discende quindi il proposito moderno degli Stati occidentali di esportare la democrazia, anche per mezzo della guerra, per promuovere la pace, la prosperità economica, la sicurezza ed i diritti umani. L’esportazione forzata della democrazia, tuttavia, crea un paradosso che mina i principi stessi di essa e dei paesi che se ne considerano paladini ovvero l’accettazione della diversità, la libertà e l’autodeterminazione dei popoli.

Cos’è la democrazia
La democrazia ha subito una forte evoluzione nel corso del tempo. Se nell’antica Grecia vigeva la partecipazione diretta dei cittadini al potere politico, oggi la democrazia si basa sull’elezione di rappresentanti dei cittadini e il volere del popolo è limitato dalla legge al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Nonostante non ci sia una definizione universalmente riconosciuta del termine democrazia, per consensus uno Stato può essere definito democratico se al suo interno sono garantiti il suffragio universale, le elezioni libere, corrette e ricorrenti, la pluralità dei partiti, la competitività e la libertà di stampa (Cotta, 2001).
È, tuttavia, impossibile vedere la democrazia solo come una forma di governo senza considerare l’immediata associazione tra questa e le grandi conquiste sociali. Tra queste figurano la libertà di parola, l’uguaglianza formale tra le persone e lo sviluppo economico.
Metodi di esportazione del modello democratico
Esistono diversi metodi per esportare la democrazia. Quello più comune è la guerra. La democratizzazione forzata, attraverso il cosiddetto “metodo del bastone”, prevede l’utilizzo di mezzi coercitivi che, inevitabilmente, non coinvolgono solo i leader autoritari, ma anche la popolazione civile e contribuiscono ad acuire la violenza e la frammentazione interna ai Paesi oggetto di esportazione (Basso, 2017).
La democratizzazione attraverso il “metodo della carota”, al contrario, prevede un processo volto a modificare progressivamente le istituzioni governative e a diffondere e consolidare le idee di uguaglianza e libertà tra la popolazione in modo pacifico (Archibugi, 2009). L’utilizzo di strumenti di soft power come la persuasione, gli incentivi e la collaborazione internazionale non creano problemi etici di cui le democrazie esportatrici si devono fare carico e contribuiscono a migliorare il livello democratico all’interno degli stessi Paesi esportatori. Inoltre, il “metodo della carota” permette di evitare il sorgere di incongruenze tra i mezzi e il fine. La democrazia e la pace possono essere raggiunte con maggiore facilità attraverso l’utilizzo di mezzi coerenti.

Esportazione della democrazia e diritto internazionale
L’esportazione forzata della democrazia senza tenere conto dell’autodeterminazione e della volontà dei popoli mina alcuni dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico internazionale (Sinagra, 2015). Vengono messi in discussione il principio di parità giuridica tra gli Stati e il principio di integrità territoriale. In questo modo la comunità internazionale non è più vista come orizzontale. Diviene anzi una comunità nella quale gli Stati più forti economicamente e politicamente assumono una posizione egemonica nei confronti degli altri (Quadri, 1949).
L’esportazione della democrazia attraverso l’uso della forza mette, inoltre, in discussione il principio di non aggressione sancito dall’articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite. In tal caso parliamo del principio di non ingerenza negli affari interni. Quest’ultimo vieta tutti gli interventi volti a condizionare le decisioni politiche interne ed esterne degli altri Paesi.
Obiettivi all’apparenza nobili come l’esportazione della democrazia di stampo occidentale, dunque, vengono strumentalizzati al fine di giustificare “guerre democratiche”. Non soltanto: vanno a nascondere gli interessi economici degli Stati esportatori, i quali vengono accusati di non aver abbandonato del tutto le abitudini imperialiste (Zolo, 2010).

Il caso dell’Iraq
In Iraq nel 2003 è stata applicata per la prima volta in modo pratico la dottrina Bush della guerra preventiva. L’intervento armato unilaterale, voluto in modo particolare dagli Stati Uniti al fine di eliminare le presunte armi di distruzione di massa e di far cadere il regime di Saddam Hussein, non era stato autorizzato dal consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Risulta quindi illegale secondo il diritto internazionale. Il processo di democratizzazione del Paese a seguito della caduta di Saddam non è risultato semplice e veloce come previsto dall’Amministrazione americana. La democrazia è stata esportata con la forza, senza coinvolgere attivamente la popolazione, la quale ha percepito il regime democratico come una mera imposizione da parte di una potenza occupante.

L’Iraq post-Saddam, ancora annoverato tra i regimi autoritari dal Democracy Index dell’Economist Intelligence Unit, è caratterizzato da una profonda insicurezza economica, politica e fisica. La corruzione è estremamente diffusa e l’avvento della democrazia non è riuscito a migliorare in modo significativo le condizioni di vita dei cittadini iracheni. Al contrario, la democratizzazione forzata ha fatto sorgere un sentimento antioccidentale tra i cittadini iracheni. Il gruppo terroristico di Al-Qaida non è stato indebolito, come auspicato. Addirittura ha incrementato le sue opportunità di reclutamento all’interno del territorio (Fawcett, 2023). L’intervento statunitense in Iraq ha avuto un impatto destabilizzante per l’intero sistema internazionale. Questo non ha favorito gli interessi occidentali in quanto, oltre alla caduta del regime del Rais, ha fallito nell’intento di esportare la democrazia per pacificare il Medio Oriente e per estirpare il fenomeno del terrorismo (Acharya et. al, 2011). I controversi risultati prodotti dalla guerra in Iraq hanno esposto i limiti dell’esportazione forzata della democrazia. Non soltanto: hanno contribuito ad aumentare lo scetticismo nei confronti dell’ordine mondiale a guida americana e hanno causato danni reputazionali agli Stati Uniti, accusati di essere una potenza neo imperiale.
Conclusioni
L’esportazione della democrazia diventa così uno degli obiettivi cardine della politica estera americana dalla caduta del blocco sovietico al fine di consolidare la propria egemonia e di stabilizzare il nuovo ordine mondiale, con la convinzione che, come teorizzato nella teoria neokantiana, le democrazie siano pacifiche e non si dichiarino guerra a vicenda. L’esperienza storica dell’esportazione coercitiva della democrazia in Iraq ha messo in luce il fatto che la democrazia è difficilmente esportabile con la forza senza tenere conto della volontà del popolo. Tutto questo dimostra anche che l’ideale della democrazia e la difesa dei suoi valori vengono spesso strumentalizzati al fine di giustificare l’utilizzo unilaterale della forza, anche quando non consentito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Bartholomew, 2009). Affinché la democrazia possa attecchire in un nuovo territorio risulta quindi necessario comporre un quadro politico endogeno. Tale contesto deve possedere una cultura politica adeguata. La popolazione deve aver espresso il desiderio di instaurare una democrazia e sia stata coinvolta nel processo di ricostruzione del paese a seguito della caduta del regime precedente.
Bibliografia
Acharya A., Katsumata H. (2011), Beyond Iraq: The Future of World Order, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, Singapore, 40
Archibugi D. (2009), Legality and legitimacy of exporting democracy, in “Legality and legitimacy in global affairs”, Oxford University Press, Oxford, 414-438
Bartholomew A. (2009), Legality/legitimacy: Problems and Prospect for Legality under American Empire, in “Legality and legitimacy in global affairs”, Oxford University Press, Oxford
Basso P. (2017), Iraq, Afghanistan..: genocidii da portare alla luce, in “DEP”, n.34/2017
4doi.org/10.2307/20202345 (16/08/2024)
Cotta M., Della Porta D., Morlino L. (2001), Scienza politica, Società editrice il Mulino, Bologna: 91
Doyle M. (1983), Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, in “Philosophy and Public Affairs”, 205-235 e 323-354
Fawcett L. (2023), The Iraq War 20 years on: towards a new regional architecture, in “International Affairs” Kant I. (1795), Per la pace perpetua, Sonzogno, Milano
Quadri R. (1949), Diritto internazionale pubblico, Priulla Editore, Milano
Sinagra A. (2015), Sovranità dello Stato e divieto di ingerenza nei suoi affari interni, in “Ordine internazionale e diritti umani”, 780-787
Zolo D. (2010), Violenza, democrazia e diritto internazionale, in “Jura Gentium”